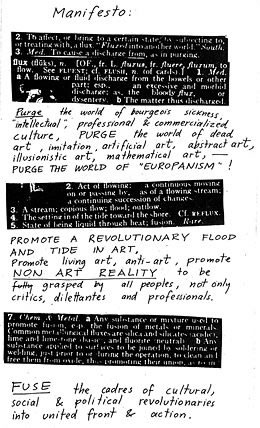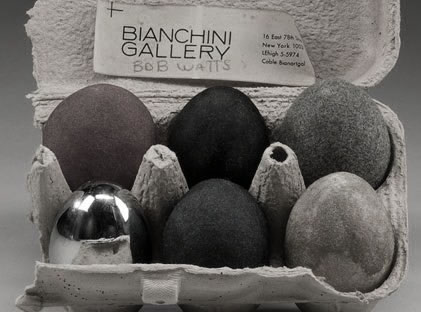QUALCHE OSSERVAZIONE SULLA RICERCA SOCIALE.

Partiamo da alcune semplici constatazioni che valgano anche come premessa. Un argomento ricorrente nelle conversazioni di tutti i giorni (della gente comune) è ciò che la gente comune fa o pensa. Si può affermare che in ogni momento siamo coinvolti in discussioni attraverso i quali si esprimono commenti, opinioni e giudizi sul modo di vivere, sugli orientamenti culturali, sulle tendenze politiche, sui fatti di costume che attengono qualcuno o qualche gruppo sociale.
Questo interesse, in genere, non è di tipo professionale e tutto si esaurisce in osservazioni più o meno fondate, più o meno critiche, più o meno dettate dalle emozioni che lasciano le cose come sono.
In genere, per quanto possa apparire paradossale, dei fenomeni sociali di cui facciamo (o di cui crediamo di aver fatto) un’esperienza comune non c’è quasi mai una spiegazione univoca, anzi, il più delle volte le interpretazioni si collocano su posizioni totalmente contrapposte, soprattutto quanto sono accompagnate da osservazioni di natura politica o etica. Ciò avviene perché attraverso l’interpretazione dei fatti sociali noi esprimiamo i nostri giudizi di valore, o meglio, costruiamo una certa immagine della realtà e, spesso senza volerlo, la rappresentiamo come la desidereremmo. Ne consegue che, in questo processo, è facile equivocare o distorcere il pensiero degli altri, falsare o semplificare fenomeni complessi, proporre spiegazioni approssimative o avanzare previsioni errate. Le nostre rappresentazioni della realtà, in altre parole, possono risultare parziali o prive di fondamento, anche se siamo soggettivamente convinti di quello che affermiamo.
Va da sé, tutto questo avviene anche perché non sempre disponiamo delle informazioni o dei mezzi necessari per poter esprimere valutazioni pertinenti. L’esperienza della gente comune, infatti, è diretta, ma non sempre è tale da consentire delle generalizzazioni, sia perché questa esperienza è giocoforza parziale, sia perché raramente si possono estendere o siamo in grado di estendere le nostre deduzioni al di là del nostro ambito sociale.
C’è poi il grande problema dei pregiudizi sociali, cioè, dei condizionamenti culturali, politici e religiosi che confondono le capacità di osservare o di restare neutrali. Questo tipo di condizionamento può non essere percepito o non apparire evidente per il semplice fatto che il più delle volte si presenta come un atteggiamento selettivo nei confronti delle informazioni che riceviamo o che sono a nostra disposizione. All’origine di questo atteggiamento vi possono essere motivi ideologici, etici, di appartenenza ad una certa comunità, come è sempre più frequente oggi con l’accentuarsi dei flussi migratori, o più semplicemente questo atteggiamento è il frutto di un’adesione a certi luoghi comuni che si riproducono facilmente all’interno degli ambienti sociali nei quali viviamo o che ci sono veicolati dai mass-media. In questo contesto il pericolo maggiore dei pregiudizi è di distorcere la realtà sociale con spiegazioni approssimative, false o, peggio ancora, semplificative, questo perché le semplificazioni favoriscono visioni omologanti dei comportamenti e dei modi di pensare.
In politica è la strategia del cosiddetto populismo.
L’espressione di populismo ha numerosi campi di applicazione, è stata spesso usata anche per indicare movimenti artistici e letterari, ma il suo ambito principale rimane quello della politica.
Il largo uso che oggi i politici e i media fanno del termine populismo ha contribuito a diffonderne un’accezione che lo mette sullo stesso piano della demagogia, un termine di origine greca (composto di demos, "popolo” e agein, "condurre, trascinare") che indica un compiacimento incline ad assecondare le aspettative della gente sulla base della percezione delle loro necessità, per ottenere consenso.
Così, se c’interessa ricostruire in modo corretto i caratteri e le circostanze in cui si manifesta un determinato fenomeno sociale il “percorso dell’osservazione” deve essere necessariamente più articolato e complesso, superare lo stadio dell’esperienza soggettiva e dell’informazione semplificata. Occorre operare indagini, ricercare dati e analizzarli obiettivamente, occorre mettere i dati in relazione tra di loro, avanzare interpretazioni e sottoporle a verifica e a giudizio.
Si tratta in sostanza di passare da un approccio legato al senso comune ad un approccio cognitivo, oggettivo e scientifico.

Vediamo ora meglio che cos’è la ricerca sociale.
Come abbiamo accennato la ricerca sociale si occupa della raccolta e dell’interpretazione dei dati alla scopo di rispondere a domande concernenti i diversi aspetti della società, permettendoci così di comprenderla o al limite d’individuarla, può essere pura o applicata.
La prima consente di elaborare e verificare teorie e ipotesi che saranno utili in futuro, ma che non sono direttamente applicabili per risolvere problemi sociali concreti. La seconda, invece, propone risultati utilizzabili per risolvere problemi sociali di interesse immediato.
In generale i metodi di ricerca sono importanti perché ci consentono di generare e controllare teorie e ipotesi metodologicamente corrette, evitando i rischi dell’interpretazione soggettiva. Da un punto di vista epistemologico possiamo affermare che nella ricerca sociologica non esistono né teorie, né ipotesi puramente deterministiche o di portata generale, così come sono rari i casi di ricerca che invalidino una teoria in modo univoco. C’è poi da osservare che esistono vasti settori della realtà sociale in cui non esistono teorie in senso proprio, ma solo schemi interpretativi, apparati categoriali, sistemi tipologici, definizioni. La ricerca sociale, in sostanza, è prevalentemente una ricerca empirica, ovvero vincolata a conoscenze fattuali acquisite sul campo o in laboratorio, quali osservazioni, questionari, interviste, documenti, esperimenti.
Gli obiettivi di una ricerca sociale sono principalmente tre:
Descrizione. Spiegazione. Previsione di una data realtà.
Diciamo da subito, però, che la pretesa di una descrizione oggettiva della realtà è un mito, questa “configurazione” della realtà non esiste e non può esistere. Per ciò le scienze sociali hanno imparato ad elaborare dei modelli empirici con i quali accostarsi ai fenomeni sociali, individuali o collettivi che siano. Le spiegazioni in sociologia, infatti, derivano quasi sempre dal modello deduttivo. Vale a dire, perché sussista una spiegazione deve esistere una regolarità nella frequenza dei fatti. Tale regolarità, poi, può consistere in una correlazione casuale o funzionale.
La deduzione è un termine di origine latina, deriva dal verbo deducere. Rappresenta quel processo logico per cui da un assunto iniziale, attraverso una serie di passaggi logici necessari (inferenze), si derivano determinate conclusioni. La deduzione è quindi quel processo che permette il passaggio dal principio generale esposto nella premessa alla conclusione che conduce a fatti particolari. E un processo opposto all’induzione. Esempio tipico di deduzione: "Tutti gli uomini sono mortali [principio generale], Socrate è un uomo [inferenza], Socrate è mortale [fatto particolare]".
Di fatto, la struttura logica della previsione e simile a quella della spiegazione.
Date certe premesse logiche (cioè le condizioni empiriche dell’evento e un sistema di asserzioni in forma di legge) vengono derivate le previsioni corrispondenti. Queste previsioni, poi, sono affidabili a misura che sono affidabili le asserzioni in forma di legge.
Ma che cosa è la legge in questo contesto?
Se per teoria scientifica intendiamo un insieme di ipotesi esplicative che danno conto di ricorrenze empiricamente rilevate, la legge descrive delle regolarità nella successione degli eventi empiricamente osservati. La teoria, quindi, è un sistema generale di leggi che non può essere empiricamente riscontrata se non desumendo da essa stessa le sue asserzioni o ipotesi.
L’espressione di teoria (dal greco theorein, composto da thea, "spettacolo" e horao, "osservo", ovvero "guardare uno spettacolo") indica, nel linguaggio comune, un’idea nata in base ad una qualche ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratte rispetto alla realtà.
Secondo alcune fonti il termine era usato frequentemente dagli antichi greci nel senso di "guardare" un’azione di teatro o dei giochi nell’arena. L’uomo, come abbiamo constatato più volte, è portato a costruire teorie per spiegare, predire e comprendere i fenomeni che lo circondano. Non va confusa la teoria con la supposizione, questa, poi, se è astratta, vale a dire non è basata sull’osservazione si definisce con il termine di congettura, mentre se è basata su delle osservazioni è definita un’ipotesi. La maggior parte delle teorie iniziano come ipotesi, ma molte ipotesi risultano false e non diventano teorie. Una teoria, poi, è diversa da un teorema che è un’affermazione matematica che segue logicamente da un insieme di assiomi. Una teoria è inoltre differente da una legge fisica nel senso che la prima è un modello della realtà, mentre la seconda è una descrizione di ciò che si osserva. Le teorie, dunque, non sono costruzioni astratte ma si appoggiano sull’osservazione e con l’osservazione devono venire validate, in particolare controllando le previsioni che esse consentono di fare. È importante notare che il termine "teoria", nelle scienze, ha un significato diverso da quello del linguaggio comune e questo è fonte di fraintendimenti. Nel linguaggio comune, la frase "È solo una teoria" può essere utilizzata per insinuare che certe teorie sono sgradite. Nella scienza, un insieme di descrizioni e modelli è chiamato teoria solo se ha una solida base empirica.

Torniamo al nostro argomento. Più in particolare, la ricerca sociale è un attività di ricerca che implica una dimensione empirica d’indagine. In pratica è un’attività che consiste in un processo di acquisizione, di analisi e d’interpretazione di dati relativi a fenomeni sociali e culturali che riguardano degli individui, dei gruppi, delle categorie sociali o, al limite, delle comunità.
Ogni ricerca sociale, dunque, nasce dall’osservazione e si alimenta delle teorie che consentono di oggettivarla ed analizzarla. In sociologia si parla di macro e/o di micro-sociologia in funzione della prospettiva con la quale si vogliono cogliere determinati atteggiamenti. Per riassumere. Da una parte è vero che la cultura, i sistemi normativi, le istituzioni e i ruoli condizionano gli atteggiamenti, i valori, l’identità. Dall’altra è vero anche che la società si costruisce e si definisce attraverso i processi di interazione sociale che si stabiliscono tra gli individui, attraverso i significati che si attribuiscono alla realtà e attraverso le forme di negoziazione che li rendono comuni.
Insomma, la società definisce gli individui in quanto attori sociali, ma, a sua volta, è definita da essi.
I fenomeni presi in considerazione dalla ricerca sociale sono i più diversi anche se tra di essi, in genere, sono prevalenti quelli che riguardano l’organizzazione della vita collettiva, l’interpretazione delle trasformazioni, gli stili di vita, le modalità di formazione delle relazioni umane, i conflitti, i comportamenti e gli atteggiamenti individuali e collettivi, le mode e i consumi. In generale, le informazioni sulle quali si concentrano più frequentemente le ricerche possono distinguersi in due grandi gruppi. Il primo gruppo comprende le informazioni che permettono di descrivere gli aspetti che caratterizzano gli orientamenti individuali (dai comportamenti, alle convinzioni, alle conoscenze, alle preferenze, ai ruoli, agli status). Sono informazioni che si prestano ad essere descritte e che sono oggettivabili con la memoria, il ragionamento, la valutazione, in una, attraverso processi di tipo cognitivo. Il secondo gruppo comprende le informazioni che riguardano le motivazioni, le aspettative, i valori, la percezione di sé, gli stati d’animo.
Sono informazioni che implicano introspezione ed una elaborazione soggettiva della realtà, dunque difficilmente comparabili e misurabili. Questo tipo d’informazioni sono estremamente preziose nella ricerca sociale perché consentono di ricostruire gli atteggiamenti sociali a partire dal vissuto individuale. La scientificità di una ricerca in sociologia dipende in primo luogo dall’accuratezza con cui vengono definiti i suoi obiettivi in rapporto alla natura del fenomeno in esame e dalla chiarezza delle procedure adottate in ogni fase della ricerca stessa.

Le fasi attraverso cui si dispiega la ricerca sono:
Definizione dell’oggetto –progettazione (operativa) –rilevazione e osservazione –analisi.
La definizione dell’oggetto della ricerca presuppone la definizione “concettuale” dei fenomeni implicati. Nella stessa definizione, infatti, possono esserci molti significati, ciascuno dei quali rinvia a dimensioni interpretative diverse dello stesso fenomeno. Una volta definito e circoscritto il fenomeno da studiare si prendono in considerazione i temi ad esso connesso e si identifica l’insieme delle informazioni di cui si ha necessità per procedere. I concetti utilizzati per descrivere un fenomeno devono in pratica tradursi in informazioni concrete rilevabili attraverso l’attività d’indagine. La definizione di una tale mappa tematica rappresenta un momento di messa a punto concettuale dei contenuti e delle ipotesi della ricerca che devono, a loro volta, potersi giustificare alla luce di un quadro teorico più generale. Nelle scienze sociali esistono molti approcci di ricerca, alcuni anche molto antichi e collaudati, ma la distinzione più generale è quella tra ricerche di tipo quantitativo e ricerche di tipo qualitativo. La distinzione tra i due approcci consiste nel fatto che la ricerca quantitativa ha alle sue spalle una concezione positivista delle scienze sociali per la quale la realtà sociale e assunta come se fosse un dato oggettivo, dunque rilevabile, misurabile e suscettibile di spiegazione. La ricerca qualitativa, invece, parte dal presupposto che ogni rappresentazione della realtà è sempre l’espressione di una costruzione sociale nella quale il senso deriva non solo dagli attori sociali che vi partecipano, ma anche dalla posizione sociale di chi la compie. In altre parole si contrappone alla presunzione di oggettività dell’analisi scientifica la consapevolezza della relatività di ogni ricostruzione della realtà sociale.
L’accuratezza nella rilevazione dei dati dipende, in generale, dalle conoscenze già disponibili sul fenomeno indagato e, in particolare, da tre fattori:
– La sua circoscrivibilità concettuale e fenomenica.
– Il grado di osservabilità e misurabilità.
– La possibilità di avanzare ipotesi interpretative convincenti.
Nella fase finale dell’analisi, infine, l’insieme dei dati e delle informazioni acquisiti diventa oggetto di specifiche elaborazioni e valutazioni allo scopo di:
– Descrivere il fenomeno.
– Costruire delle tipologie utili sul piano analitico come sul piano della sintesi dei dati acquisiti.
– Avanzare delle interpretazioni o delle spiegazioni, ovvero, ipotizzare dei rapporti o delle connessioni.
I metodi d’indagine più usati nell’indagine quantitativa sono l’inchiesta campionaria, il sondaggio d’opinioni e l’indagine a carattere sperimentale. Le tecniche usate per l’acquisizione delle informazioni prevedono soprattutto l’uso del questionario o del test.
La ricerca qualitativa, invece, piuttosto di assumere la realtà sociale come una realtà indagabile e oggettivabile, muove dal presupposto che ogni interpretazione è una costruzione di senso e si da come obiettivo quello di riconoscere le rappresentazioni e il significato che gli attori sociali danno di tale realtà.
I metodi d’indagine più usati dalla ricerca qualitativa sono il metodo etnografico (con il quale si studiano le strutture culturali, i comportamenti, le credenze), e il metodo biografico basato sugli studi del caso.
*****

Un appunto sulle forme – strategiche e tattiche – della comunicazione sociale.
Qualunque sia il punto di partenza di un qualunque processo sociale inevitabilmente l’attore o gli attori sociali devono passare attraverso la filiera della teoria della decisione. Infatti, ogni azione è la conseguenza di una decisione!
In altri termini ciò che qui interessa è rispondere alla domanda: Come un individuo sceglie o può scegliere tra opzioni determinate in funzione dei suoi interessi o degl’interessi dell’entità alla quale fa riferimento? (…tutto questo, naturalmente, dando per scontato che l’individuo sia in grado di scegliere.)
In questo quadro il sistema ruota attorno a due nozioni base: L’azione come processo, da una parte, gli attori che vi partecipano, dall’altra. In questo senso, è necessario definire prima l’azione e, in un secondo tempo, passare a descrivere il comportamento degli attori.
Noi definiamo azione un processo nel corso del quale uno o più attori effettuano delle scelte.
L’azione, in questo senso, consiste nel fenomeno osservato.
Occorre notare che il contributo degli attori all’azione riposa sul loro comportamento e non in quelle che sono o potrebbero essere le loro intenzioni. L’azione, poi, si situa in un ambiente, cioè, dentro un sistema di variabili trasformate dall’azione stessa o suscettibili di essere trasformate.
Da qui una prima conseguenza: Lo svolgersi dell’azione è osservabile a partire dagli avvenimenti, cioè, dalle trasformazioni dell’ambiente. Queste trasformazioni sono costatate e stimate dagli attori, ma è frequente che questi attori non valutino allo stesso modo le stesse cose e quindi finiscano per valutare le trasformazioni in modo diverso.
L’attore e l’agente.
L’attore è l’individuo isolato o l’organizzazione suscettibile di effettuare le scelte. Di contro, un’organizzazione partecipa al processo d’azione tramite un agente. In questo senso un agente è un individuo che incarna un attore al momento dell’azione. Questa distinzione tra attore ed agente discende dal fatto che un’organizzazione è allo stesso tempo un’entità determinata e una collettività dove coesistono delle procedure e degli ambiti operativi. Inversamente un individuo non può giocare un ruolo in un’azione senza incarnare, anche solo in parte, un’organizzazione. Paradossalmente questa distinzione tra attore ed agente ricorda quella tra persona fisica e persona morale. Ci sono casi in cui l’agente può rappresentare completamente l’attore, come nel caso di un amministratore delegato con pieni poteri. In ogni modo l’attore resta sempre l’organizzazione con i suoi atti particolari.
L’atto e l’effetto di un atto.
L’effetto di un atto si compone di avvenimenti – cioè, di modificazioni di variabili – o di operazioni di mantenimento dello status-quo. Va tenuto presente, però, che l’effetto di un atto non sempre è immediatamente successivo ad un atto. Può succedere che l’effetto sopraggiunga molto dopo e questo perché, per esempio, il processo – che contiene l’atto – non è immediatamente apparente. E’ quello che, nelle scienze naturali, viene definito periodo d’incubazione. Ma può darsi anche il caso che lo svolgimento del processo che contiene l’atto venga successivamente occultato o modificato o messo in gioco visivamente più tardi. Nei giochi di strategia questo intervallo di tempo non è né un handicap né un vantaggio, ma può diventare uno dei due nel decorso dell’azione. In questo quadro l’effetto, come condizione dell’esistenza dell’atto, come inveramento dell’atto, permette di valutare la pertinenza dell’informazione iniziale o di modificarne la traiettoria nel tempo del processo anche indipendentemente dalle intenzioni degli attori.
Il decisore, la decisione.
Nella misura in cui le intenzioni degli attori sono dissociate dal (loro) comportamento osservabile, e questo comportamento osservabile a sua volta può essere distinto dagli effetti che gli succedono nel tempo, si deve distinguere tra atto e decisione. Nella pratica: Non esistono azioni semplici, ma solo azioni complesse (che dall’esterno possono apparire esemplari!) e che, in genere, fanno intervenire più di un attore, tra cui i “decisori”. (Qui definiamo “decisori” gli attori che prendono la “decisione”, cioè, selezionano una intenzione che inverano nell’atto al seguito del quale l’azione sarà modificata.) Non esistono decisioni che non verticalizzino il tempo, nel senso che una decisione è la condizione di un cambiamento, ma anche di un possibile pregiudizio sugli effetti a venire. La decisione, insomma, ha un carattere destinale. La decisione collima con l’atto solo in un caso, quando verifica un’ipotesi deterministica, cioè, esiste una certezza degli effetti dell’atto.
Può darsi il caso che gli effetti sperati dal decisore non si concretizzino ( Motivo? L’informazione insufficiente, la mancanza di una razionalità nell’azione, il sopraggiungere d’impedimenti non prevedibili). In questo caso occorre dissociare le intenzioni proprie dell’attore dal suo comportamento, come dagli effetti del suo comportamento. Perché? Perché l’osservatore, se definiamo la decisione come una selezione dell’intenzione che s’invera in un atto, non potrà mai osservarla direttamente. Come fare? Procedere alla destrutturazione dei concetti in modo da poterli ricombinare in maniera dinamica con logiche diverse. La logica di chi agisce, la sua volontà e la sua percezione dell’azione sono, infatti, le combinazioni da cui dipendono gli effetti del suo atto.
In ogni modo, ogni cambiamento di comportamento “traduce” e “tradisce” le intenzioni dell’attore e riflette le regole dell’azione.
Osserviamo ancora questo, nella pratica un atto non rinvia quasi mai ad una decisione definitiva. Più che un atto isolato è la successione degli atti che permette di tarare progressivamente le intenzioni degli attori. Di contro, per agire su un azione non è affatto necessario conoscere sempre queste intenzioni.
Va da sé, un attore diventa un decisore nel momento in cui prende una decisione che s’invera in un atto e, questo ruolo, può essere strategicamente alterato per ingannare sulla sua identità. Ancora, si possono avere atti che sono senza decisione e dunque senza decisore. E’ il caso degl’atti riflessi. In ogni modo nella sociologia della comunicazione l’effetto è sempre attribuito all’atto e non alla decisione.
Le decisioni collettive, le coalizioni.
Quando le decisioni sono prese da un gruppo di attori possiamo distinguere due casi:
Uno. Quello della decisione collettiva. Una decisione è collettiva quando il decisore è costituito da un gruppo di attori che seguono le stesse regole di comportamento. Due. Si tratta di una coalizione quando gli atti degli attori sono coordinati per essere concomitanti. ( Per conseguenza, si definiscono “istituzioni” le decisioni collettive di natura perenne. E’ il caso dei parlamenti, per esempio).
Per riassumere:
Un attore è una organizzazione che partecipa ad una azione, ed essa è rappresentata da agenti che sono degli individui. I due termini si sovrappongono solo in un caso, nell’azione individuale, quando l’agente non rappresenta che se stesso. Gli atti compiuti da un attore si costatano dal cambiamento di comportamento e dal loro effetto. Non sempre gli effetti previsti sono quelli voluti.
Un atto senza decisione e l’atto di riflesso. La decisione può essere collettiva o di coalizione.

La fase, la sequenza, la regola il transfert.
L’azione può essere destrutturata in periodi lunghi (fasi) o in periodi brevi (sequenze). Nella fase ci sono azioni che possono coinvolgere o non coinvolgere il sistema dato, con il risultato che ci sono delle relazioni che mutano immediatamente ed altre che possono restare inalterate. C’è un cambiamento di fase quando la più parte delle relazioni sono state trasformate, non importa il modo, cioè, per cause interne – come conseguenza degl’atti – o esterne. In questo caso i contrasti nel comportamento degli attori si trasformano a loro volta generando nelle nuove regole o confermandone altre. Attenzione: la trasformazione di una o più regole che si produce all’esaurirsi di una fase costituisce una sorta di “transfert”, cioè, una modificazione nella coercizione del comportamento. Gli effetti di una decisione, per altro, sono suscettibili anche di provocare un transfert che la trasforma, al di fuori, spesso, delle intenzioni del decisore.
Abbiamo detto che una fase determina una durata tra due cambiamenti di regole. Ciò non toglie che si possano studiare una serie di fasi senza conoscerne necessariamente l’origine o il fine.
Nel corso di una fase si possono enucleare dall’azione episodi autonomi o che si succedono o che coesistono, a questi daremo il nome di sequenze. Dunque la sequenza è un processo s’azione autonomo delimitato nel tempo all’interno di una fase. Perché è importante la determinazione delle sequenze? Perché essa permette di distinguere, quando è necessario, i ritmi o i modi di evoluzione che compongono la fase. Infine, quando le decisioni o gli atti devono sottostare a delle regole di funzionamento si definiscono queste regole come procedura.
Percezione dell’azione.
Dobbiamo considerare l’azione anche sotto l’aspetto di successione di informazioni dalle quali gli attori prelevano certi dati – variabili di stato e di rappresentazione – secondo un certo modo di giudicare la situazione generale. Gli attori creano anche dell’informazione – sia nel momento in cui l’atto s’invera, sia nella sua attuazione – ed, inevitabilmente se le scambiano. Soprattutto, stabiliscono delle relazioni di dominanza che determinano le negoziazioni.
Ci sono variabili di stato e variabili di rappresentazione.
Le variabili che compongono l’ambiente sono chiamate variabili di stato, il loro numero e le loro caratteristiche variano nel corso di un’azione. Qui, l’attore che partecipa all’azione non necessariamente conosce o possiede dei dati obiettivi su di esse. Noi chiamiamo variabili di rappresentazione la stima che un attore può dare di un’altra variabile che può essere, indifferentemente, di stato o di rappresentazione.
E’ il paradosso dei due uomini chiusi in una stanza. “A” pensa che piove – variabile di rappresentazione di una variabile di stato. “B” pensa che “A” creda che non piove. In questo caso “B pensa che A creda che non piove”, cioè, quello che pensa “A” è per “B” una variabile di rappresentazione. Come è facile costatare queste due categorie di variabili procurano all’attore dei convincimenti suscettibili di trasformare il suo comportamento.
Possiamo dire, a questo punto, che l’effetto costituisce spesso una transizione tra due atti dello stesso attore. E’ il caso della finta nella boxe nella sequenza uno, parata, due a segno, come conseguenza della parata che ha sbilanciato l’attaccato. Così, per “A” come per “B”, l’effetto di un atto deve essere costatato senza tener conto delle decisioni ipotetiche dell’attore che lo ha effettuato, perché, sul piano della prassi, la trasformazione della traiettoria di certe variabili previste al momento della decisione sono quasi sempre diverse dall’effetto dell’atto. Come nella boxe, ci sono pugni virtuali che non arrivano mai, ma che determinano – a causa del loro effetto – le circostanze per l’arrivo di quelli veri!
Per conseguenza, si chiama “spazio di valutazione” quella parte dell’ambiente che si presume contenga gli effetto virtuali di una decisone o che subirà le conseguenze di un atto. In questo spazio è possibile selezionare delle “dimensioni valutative” che sono le dimensioni elementari del sotto-sistema dell’ambiente definito “spazio di valutazione”. L’utilizzazione delle dimensioni valutative permette di adattare dei criteri in funzione dell’evoluzione del processo osservato. (E’ il caso della cintura di sicurezza. Nei piccoli tragitti le dimensioni valutative dimostrano che si giudica il pericolo un vincolo più forte della norma che le prescrive, da qui la decisione di molti di non indossarle.) Si possono definire, in questo contesto, i “criteri di valutazione” come la stima scelta per valutare gli effetti virtuali di una decisione o l’effetto di un atto su una dimensione del problema in oggetto. Dalla correttezza delle dimensioni valutative, invece, discendono le possibilità di un’azione di giungere al suo obiettivo.
Annuncio.
L’annuncio è l’informazione data da uno o più attori su un cambiamento di stato di una variabile o di un cambiamento di una variabile. (Per quelli che sono restati chiusi nella stanza. “C” entra nella stanza è dice, la pioggia è cessata. L’informazione di “C” è un cambiamento di stato della variabile tempo. Non sempre gli annunci sono verbali. La finta del primo pugile per tirare il secondo colpo sul bersaglio è per il secondo pugile un annuncio! Di regola ad un annuncio segue un effetto, cioè, la trasformazione della traiettoria di una variabile in atto. (E’ il caso classico del ricatto.)
L’attore che partecipa all’azione è allo stesso tempo un decisore e un osservatore – dei propri atti e di quelli degl’altri. Ne consegue che noi dobbiamo distinguere le variabili di stato e le variabili di rappresentazione a seconda se esse sono osservate o stimate al fine di distinguere l’effetto virtuale previsto al momento della decisione – che necessariamente concerne soltanto le variabili di rappresentazione – e l’effetto reale che testimonia l’esistenza dell’atto. La differenza degli effetti può anche dipendere dal momento o dalla maniera con cui si osservano, così, è necessario distinguere tra:
L’attuazione. O l’atto che modifica direttamente l’azione per mezzo della modificazione delle traiettorie delle variabili di stato.
L’adattazione. O l’atto che modifica indirettamente l’azione modificando le variabili di rappresentazione che inquadrano il comportamento dell’attore.
La dominanza.
Un attore dominante e un attore i cui atti sono successioni di effetti che limitano le scelte di comportamento degl’altri attori o trasformano gli effetti che questi si aspettano dalle loro decisioni.

Si possono definire due tipi di dominanza: La dominanza forte è quella che trasforma le condizioni dell’attore dominato limitandolo nelle decisioni o riducendogli le scelte possibili. La dominanza debole è quella che agisce sugli effetti che l’attore dominato si aspetta dai suoi atti. Nella vita corrente è l’ambito delle minacce: se tu fai questo io allora non farò questo…
Gli esempi di dominanza sono numerosi. La dominanza può essere acquisita – si realizza nella metafora dell’accerchiamento. Strutturale – sono in genere nella forma di ordine e discendono da una gerarchia. Un attore può essere dominante su una situazione e non esserlo in un’altra, perché la dominanza non è attribuibile all’atto, ma alle relazioni tra gli attori. Da qui, l’interesse a precisare, attraverso l’utilizzazione delle nozioni di attuazione e di adattazione, le dimensioni del suo esercizio. In pratica occorre seguire le conseguenze e le evoluzioni delle multiple relazioni di dominanza, come l’utilizzo che ne fanno gli attori. (N.B. – Il concetto di dominanza è qui utilizzato nel suo significato di “termine tecnico della teoria dei giochi”.)
La negoziazione.
Si chiama così una successione di adattazioni prese dai decisori alternativamente dominanti. Si chiama negoziazione conclusa quella a cui segua un adattazione di uno o più decisori.
L’anticipazione.
Si verifica quando l’attore si comporta in modo da far coincidere le sue anticipazioni sull’azione con il suo augurio. In questo contesto, la conclusione è un avvenimento virtuale definito dall’attore come lo stato finale probabile di un’azione. La sua utilità sta nel fatto di essere un punto di riferimento per valutare la tendenza dell’azione. Va notato che l’anticipazione di una conclusione non dipende dalle preferenze dell’attore e non pregiudica il seguito degli avvenimenti. Essa, soprattutto non deve essere confusa con un obiettivo. Per conseguenza il cambiamento di regole è una “rottura”, cioè, un transfert che rimette in causa la conclusione della decisione, perlomeno da parte di un attore. Il transfert, di per se, ha la caratteristica di creare un cambiamento di fase, ma non rimette in discussione direttamente gli obiettivi, mentre la rottura li rimette in discussione direttamente.

Strategia, obiettivo, tattica.
(In generale, la strategia è quella parte dell’agire che si occupa del piano generale delle operazioni progettandolo o regolamentandone le operazioni. La tattica, cioè l’arte di predisporre un esercito, studia l’impiego delle forze sul campo e considera perciò la disposizione che deve assumere ciascuna unita organica per recare il massimo danno subendone uno minimo. Le mosse che sono più opportune per passare dall’una all’altra disposizione nel minor tempo possibile. Gli atti che servono meglio a far assumere al confronto il desiderato carattere dimostrativo, temporeggiante, offensivo, difensivo, risolutivo.)
Che la conclusione di un’azione sia prevista o non lo sia, l’attore è sempre suscettibile di stabilire un senso nel quale vuole orientare il processo e determinare uno spazio e delle dimensioni valutative. In questo senso definiamo “obiettivo” un avvenimento virtuale che un attore si augura alla fine di una fase o nel corso di un azione. Per raggiungere un obiettivo fissato l’attore prevede in maniera più o meno dettagliata una catena di cambiamenti di variabili di stato su un insieme di fasi. Questa previsione è una strategia. Ma, di fatto, una strategia dipende implicitamente anche dal modo in cui un attore valuta le regole, perché sono esse che determinano i cambiamenti necessari.
Dunque, non c è strategia se non ci sono delle regole. Essa traduce la concordanza tra la volontà dell’attore e lo svolgimento dell’azione. Essa non concerne che le variabili di stato e dunque risponde dell’orientamento che prende il processo dell’azione. Sotto l’influenza di fattori “esogeni” o della “tattica”, la strategia può trasformarsi nel corso dell’azione. La strategia non costituisce una concatenazioni di decisioni o di atti, né un modello di azione, essa è piuttosto una “visione” di un ordine particolare di concatenamento degli avvenimenti, qualunque sia l’origine di questi ultimi, secondo delle regole supposte di azione. Per meglio concretizzare una strategia o conservarla l’attore deve utilizzare delle “tattiche”. La tattica è la successione delle combinazioni di decisioni presa in considerazione da un attore al fine di creare degli effetti che producono dei cambiamenti di stato favorevoli alla realizzazione di una strategia. Alla fine, la tattica non costituisce una semplice messa in opera della strategia, ma una mediazione tra la strategia dell’attore e l’azione alla quale egli partecipa per il confronto successivo degli effetti virtuali o reali, perché a partire dal momento in cui la decisione è tradotta in atto, il decisore è spossessato dei suoi effetti.
Per riassumere:
La strategia è – al suo livello più basso – all’altezza della fase.
La strategia è per sua natura virtuale.
Con la strategia l’attore seleziona delle tappe dell’azione che vanno nel senso di un obiettivo, proiettando la sua volontà nell’azione virtuale e realizzandola.
La tattica è di durata variabile, ed essa amalgama gli effetti reali e quelli virtuali, le strategie e lo svolgersi dell’azione. Essa può padroneggiarsi al meglio solo nel suo dispiegarsi.
Come cartina di tornasole dell’efficacia strategica essa è continuamente comparata a questa attraverso l’azione reale.
Occorre sempre distinguere, quando è possibile, una decisione strategica da una decisione tattica. Cioè, una decisione in cui l’attore non si attende nulla di più di un transfert virtuale e la decisione nella quale ci si aspetta un effetto virtuale diretto su una coercizione. Gli effetti virtuali di una decisione strategica sono stimati tenendo conto delle regole della fase successiva. Le decisioni tattiche creano o riducono le libertà di comportamento senza necessariamente creare una nuova fase. Per esempio, la costituzione di riserve in vista di un assedio è una decisione tattica perché diminuisce direttamente la coercizione imposta nel caso esso si verificasse. Ma essa non modifica le regole dell’assedio eventuale che consiste nell’impedire l’approvvigionamento. Così, assediare è una decisione tattica dell’assediante, perché diminuisce la libertà di comportamento degli assediati senza cambiare le regole. Infine, non tutte le decisioni sono necessariamente strategiche e tattiche, questo dipende dalle circostanze.
Il metamodello.
Come abbiamo visto l’azione è un processo complesso, scandito da fasi e da sequenze, organizzato secondo delle regole. La sua evoluzione, in genere, non è mai completamente percepita, né padroneggiata dagli attori che vi partecipano. L’azione non ha delle finalità, ma solo delle conclusioni possibili. L’attore partecipa all’azione con i suoi atti e i suoi effetti, ma questi non sono sufficienti a definire l’azione. L’attore che persegue i suoi obiettivi deve tener conto della distinzione che esiste tra la tendenza e la dinamica che si percepisce del processo concreto o apparente dei fenomeni. Queste due componenti, infatti, rendono più complessa la nozione di rischio facendo intervenire tra le variabili i tempi e la soggettività dell’attore.
Nello svolgimento dell’azione il rischio, in genere, si concretizza con l’irruzione dell’imprevisto e/o con la constatazione di un mancato controllo.
Gli atti si caratterizzano per la loro funzione nell’azione. Certi possiedono delle caratteristiche particolari, sono gli atti di attuazione, procedurali, di coalizione, eccetera. Quelli che orientano particolarmente l’azione, in genere, sono tattici o strategici. Per molti atti, infine, la precisione può non essere necessaria, ma semplicemente costatata nel corso di svolgimento di un’azione.
Con questo, la nostra definizione di decisione si situa all’incrocio tra quelle che mettono l’accento sulla nozione di processo (PROCESSO CHE TRASFORMA L’INFORMAZIONE IN AZIONE) e quelle che mettono in luce la modificazione ( LA DECISIONE COME MODIFICAZIONE DI UNA NORMA). La nozione di azione, di decisione, di atto e di effetto determinano la nozione di strategia. La strategia si acquisisce, nel corso di un azione l’attore non deve necessariamente averla, cosi come può mancare di un obiettivo. E’ con la tattica che egli acquisisce certi mezzi e fronteggia le modalità della sua messa in opera. La loro concretizzazione passa per la successione delle decisioni e degli atti degli attori tra i quali certi possono essere tattici o strategici.
C’è anche da notare che l’opposizione tra lungo e corto periodo – sovente evocato nell’ambito tattico-strategico – è relativa. L’orizzonte della strategia è la rottura o il transfert, quello della tattica è un cambiamento di stato necessario. Quello che lo distingue è più la capacità di dominanza che di ritmi differenziati di evoluzione.
Fine prima parte.